SONO
Bibliografie Il Maggio dei Libri 2025 “Intelleg(g)o… dunque sono”
Intelleg(g)o
La quindicesima edizione de Il Maggio dei Libri condivide il tema dello scorso Libriamoci e sottolinea il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali.
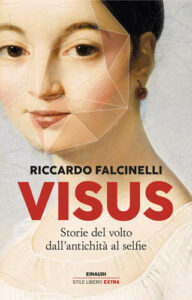
- Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie, di Riccardo Falcinelli, Einaudi (2024), 552 pp.
Il volto è ciò che siamo, ci accomuna e differenzia, ci collega con il mondo; è ciò che ricerchiamo e riconosciamo negli altri. La sua raffigurazione ha a che fare con il modo in cui siamo e con quello in cui vorremmo essere visti. Riccardo Falcinelli sviluppa queste idee ricostruendo un racconto che, attraverso immagini e testo, ripercorre la storia dell’umanità dall’antichità ai giorni nostri, prendendo in considerazione i modi in cui il volto è stato trattato nella sua riproduzione, tra pittura e fotografia, tra ricerca della somiglianza e rappresentazione della bellezza.
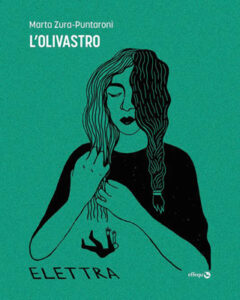
- L’olivastro, di Marta Zura-Puntaroni, Effequ (2023), 70 pp.
Un romanzo breve brevissimo di cui poco è lecito svelare. Caterina torna al paese dopo aver affrontato la vita della metropoli milanese: una vita a lei non congeniale, che non ha funzionato. Il rientro nelle Marche è vissuto come un fallimento, forse non tanto da Caterina quanto dalla madre – che si è separata è ha iniziato una nuova vita lontano dal padre – dal fidanzato, dal paese tutto a cui nulla si può tacere. La sua nuova vecchia vita sembra confermare quello che le ha sempre detto il padre, che lei è – come lui – un olivastro, selvatica e solo apparentemente inadatta alla socialità. Con una prosa spiazzante e ritmo pacato ma inesorabile, l’autrice mette sul piatto una riflessione profonda sulle aspettative genitoriali, il rapporto tra generazioni, le pressioni sociali: un finale inaspettato sorprende e diverte, aggiungendo ulteriore spessore al racconto. Le domande che rimangono aperte sono il frutto di una narrazione ben congegnata, oltre a offrire ulteriore spazio per considerazioni e confronti.

- Tomorrow, tomorrow, tomorrow, di Gabrielle Zevin, traduzione di Elisa Banfi, Nord (2023), 444 pp.
Sadie Green e Samson Masur sono amici dall’infanzia. Si sono conosciuti in ospedale quasi per caso e hanno capito subito quello che li univa: una visione del mondo unica e la grande, grandissima passione per i videogiochi. Distanti per anni si ritrovano negli anni dell’Università (lei al MIT, lui a Harvard) e riemerge forte la passione che li unisce, tanto da immaginare di mettersi in società e diventare sviluppatori. Il romanzo ripercorre i successi e gli insuccessi, le trovate geniali, le cadute, ma soprattutto è la storia di una relazione lunga una vita, costruita su una compatibilità incredibile ma allo stesso tempo con attriti inconciliabili. Sadie e Samson sono due facce di una stessa medaglia, lottano con sé stessi, con la depressione, con le loro debolezze fisiche e psicologiche. Trovano nel gioco possibilità di un’espressione artistica, rivelando quanto della loro emotività (e forse di tutti gli sviluppatori) si nasconde tra le maglie della programmazione di un gioco. Il collante che li unisce è Marx, amico fedele, praticamente devoto al sogno costruito insieme. Un sogno che inevitabilmente si scontra con la vita. Tutta quella vita che emerge potente, inarrestabile nonostante tutto, in questo romanzo che fotografa singoli e collettività, atmosfere e sentimenti.
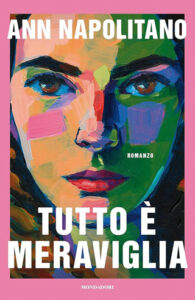
- Tutto è meraviglia, di Ann Napolitano, traduzione di Manuela Faimali, Mondadori (2024), 470 pp.
Cresciuto in un ambiente anaffettivo, con due genitori segnati dalla morte della figlia, William si ritrova avvolto dalla famiglia della sua ragazza, Julia, che al contrario di lui è dinamica, espansiva, estroversa e piena di ambizioni. La famiglia Padavano, d’altronde, è caotica e affettuosa, animata dalle personalità delle tre sorelle di Julia – Sylvie, appassionata lettrice (e bibliotecaria), Cecelia, l’artista, Emeline nata per prendersi cura degli altri – ma anche dalla tenerezza di un padre poeta poco concreto e dalla solida tempra della madre. Napolitano fotografa così le vicende di tutti, puntando il suo obiettivo su William e Julia, ma ben presto anche su Sylvie. L’idillio iniziale, però, si consuma a poco a poco, anno dopo anno, vicenda dopo vicenda, scelta dopo scelta, fino ad una rottura famigliare che sembra insanabile. Un’epica famigliare lunga decenni, capace di restituire la profondità dei sentimenti, la sorellanza nonostante tutto, i conflitti e le riappacificazioni. E la necessità di amare, sempre e comunque.
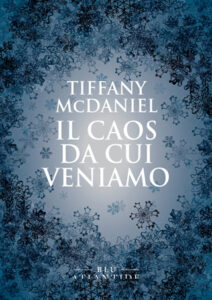
- Il caos da cui veniamo , di Tiffany McDaniel, traduzione di Lucia Olivieri, Atlantide (2021), 425 pp.
Un’appassionante storia di famiglia, lungo i decenni tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento: a determinare il tutto l’incontro tra Alka e Landon e le loro solitudini, le loro drammatiche storie. Ragazzina sottoposta a innumerevoli violenze lei, uomo costantemente discriminato lui. Si trovano, si amano e costruiscono precariamente una famiglia, mentre sono costretti a vagare per gli Stati Uniti alla ricerca di un luogo stabile in cui trasferirsi. Non sarà comunque la soluzione ai loro problemi, così come racconta Bitty, quinta figlia, voce narrante del romanzo.
In una catena di drammatici eventi la famiglia va avanti, si trasforma, fa i conti con una società crudele, spietata: tra metafora e simbolismo e un pizzico di realismo magico, l’autrice racconta una storia ispirata alla biografia della madre.
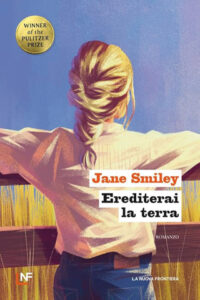
- Erediterai la terra, di Jane Smiley, traduzione di Raffaella Vitangeli, La Nuova Frontiera (2024), 448 pp.
Tre sorelle si ritrovano a fare i conti con l’improvviso cambio di atteggiamento del padre, che in Iowa porta avanti la fattoria di famiglia, quella che dopo generazioni di Cook ora è al massimo del suo splendore, a dispetto dell’inospitalità dei luoghi. Larry decide di punto in bianco di mollare tutto e lasciare la fattoria alle tre figlie. Due, Ginny (la narratrice) e Rose, sono senza parole ma accettano di buon grado oneri e onori del caso. La minore, Caroline, è l’unica a opporsi, incorrendo nell’ira del padre che la caccia e disereda. Le vicende che si susseguiranno porteranno le sorelle a riguardare con occhi diversi al loro passato, alle scelte fatte, al rapporto con il padre. Una moderna proposta del re Lear shakesperiano, dove, a detta della stessa autrice, le figlie del monarca hanno diritto di parola.
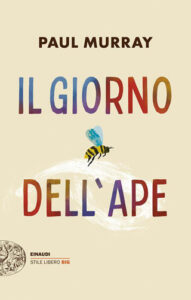
- Il giorno dell’ape, di Paul Murray, traduzione di Tommaso Pincio, Einaudi (2025), 664 pp.
Sotto la lente di Murray ci sono una famiglia e le dinamiche famigliari che si innescano quando quelle che – da fuori – paiono solide basi economiche e relazionali crollano inesorabilmente, una dopo l’altra. In un’Irlanda contemporanea si muovono i Barnes. A partire da Cass, adolescente che affronta gli ultimi anni di scuola superiore, preda di un’amicizia etichettabile come tossica, la scoperta dei primi amori, la tendenza ad autoboicottarsi per punire la famiglia o forse sé stessa. La madre Imelda, dal canto suo, ha completamente smesso di capirla, non riesce a trovare un punto di contatto con quella figlia cresciuta in un ambiente sociale così diverso da quello in cui si è trovata a nascere e crescere lei, che ha passato una vita a scrollarsi di dosso il pregiudizio. Il passato bussa con vigore alla sua porta ed è inevitabile ripercorrere i momenti che l’hanno portata lì, in quella casa, in quella situazione, forse suo malgrado o forse no. Il marito, Dickie ha ormai mollato ogni freno: la concessionaria sta fallendo e non sente la necessità di intervenire in alcun modo. L’unica sua preoccupazione è costruire un rifugio nel bosco, da cui proteggere la sua famiglia da qualsiasi catastrofe stia per abbattersi su di loro. Ad affiancarlo c’è PJ, figlio dodicenne che medita la fuga.
Quattro sguardi che si intrecciano, quattro punti di vista per una storia di famiglia che con ritmo serrato travolge ogni considerazione preesistente e, con un colpo di coda spiazzante, conduce ad un finale a dir poco sorprendente.
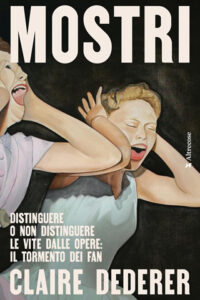
- Mostri. Distinguere o non distinguere le vite dalle opere: il tormento dei fan, di Claire Derderer, traduzione di Sara Prencipe, Altrecose (2024), pp. 320.
Qual è il legame tra la vita di un artista e la sua creazione? Siamo disposti ad apprezzare un’opera d’arte anche quando scopriamo che è stata realizzata da qualcuno che considereremmo un mostro? Questo racconto autobiografico, che prende in considerazione alcuni casi illustri della storia recente – da Roman Polanski e Woody Allen a J.K. Rowling – interroga nel profondo il nostro essere spettatori, chiedendoci quanto la nostra esperienza dell’arte sia oggi influenzata dalla consapevolezza e dal giudizio sulla biografia dell’artista; una lettura che sfida a relazionarci con il conflitto introspettivo che nasce quando non riusciamo a smettere di amare l’arte di chi ha mostrato un lato oscuro della sua umanità.

